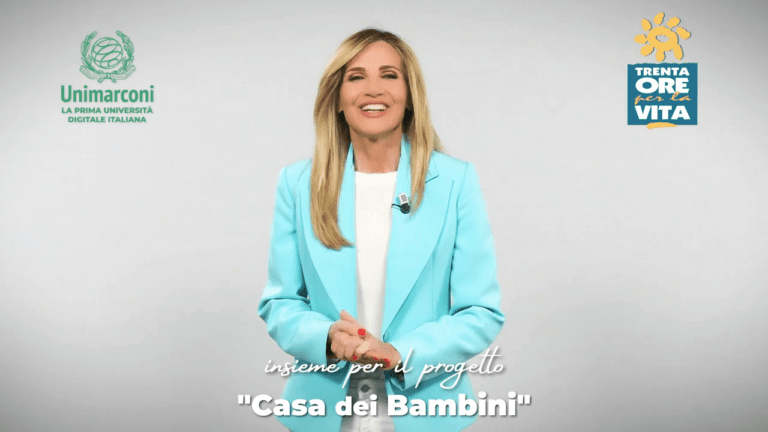«Non dobbiamo avere paura di parlare della malattia: i nostri figli non ne hanno, siamo noi che ancora abbiamo questo tabù». Giacomo Campiotti, regista di Braccialetti Rossi, ha le idee molto chiare sulla necessità di affrontare argomenti così delicati come i tumori infantili. Abbiamo chiesto al regista dell’amatissima serie, in questi giorni è in onda la seconda serie su Rai 1, le sfide che ha dovuto affrontare in questo suo lavoro.
Una storia come quella di “Braccialetti Rossi” non è come tutte le altre. Come si è posto verso questo lavoro?
Sicuramente è una storia particolare, anche se nella mia carriera già mi era capitato di raccontare temi come la malattia e la morte: verso questi argomenti poi sono particolarmente sensibile, perché il mio sogno di bambino era quello di fare il medico. Quando ho avuto la possibilità di fare Braccialetti Rossi ero consapevole di avvicinarmi a un progetto complicato, ma ho subito colto l’opportunità di poter rompere un tabù, quello dei bambini e dei ragazzi che si ammalano di cancro.
 Secondo lei perché questo argomento è ancora un tabù?
Secondo lei perché questo argomento è ancora un tabù?
Secondo me siamo un Paese molto edonista: abbiamo il culto della bellezza e della salute, viviamo nella costante speranza di non invecchiare mai. Negli altri Paesi capita spesso di vedere persone malate o in carrozzella per strada, a teatro, persino in discoteca; in Italia no, si tende a nascondersi. Io credo che questo atteggiamento è uno dei fattori della crisi di valori in cui ci troviamo. Ma dobbiamo guardare in faccia la realtà: il cancro esiste, e colpisce anche i bambini.
Uno dei commenti che mi fanno più spesso è «Braccialetti Rossi è bello, ma non riesco a guardarlo perché mi intristisce». Invece io credo che i nostri ragazzi sono molto più coraggiosi di noi e vogliono affrontare questi argomenti, perché parlare della malattia e della morte aiuta a dare un senso alla vita. E il messaggio del libro di Albert Espinosa è proprio questo: anche nella malattia è possibile trovare un senso.
In occasione del Festival di Giffoni, lei e il cast siete stati in visita all’ospedale pediatrico di Salerno. Com’è stata l’esperienza di incontro con i malati?
L’incontro con la malattia è stato molto forte, perché negli ospedali c’è davvero tanto dolore. Ma quella visita non è stata l’unica attività del genere. Fin da subito abbiamo deciso di organizzare in occasione degli appuntamenti pubblici con i ragazzi incontri significativi a livello educativo: ecco perché abbiamo scelto di visitare dei reparti pediatrici, e sul set della seconda serie ci sono anche venuti a trovare anche alcuni malati. Questa scelta è nata perché volevamo dare il senso del nostro lavoro ai ragazzi: il nostro obbiettivo non sono i soldi o la fama, ma dare una voce a chi fino a ora non ne ha avuta.
In “Braccialetti Rossi” non mancano poi momenti divertenti. Come nasce la scelta di mostrare anche questi aspetti?
Volevamo offrire un cambio di prospettiva e dimostrare una cosa: anche negli ospedali capita di ridere. È vero che malattie come il cancro sono terribili, ma anche in situazioni così dure la vita può continuare ugualmente. Un ambiente stimolante e le persone giuste in questi casi sono fondamentali; una risata certamente non guarisce, ma aiuta davvero tanto l’umore dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Infatti durante le nostre visite alcuni dottori ci hanno raccontato che i bambini in genere accettano molto meglio la malattia rispetto ai loro genitori, che si intristiscono e si abbattono. I ragazzi malati di tumore si sentono poi segnati da questa tristezza, perché se ne sentono responsabili.
Secondo lei Braccialetti Rossi potrebbe offrire qualche spunto per i reparti di oncoematologia pediatrica?
Braccialetti Rossi non è un documentario, ma una storia che immagina degli scenari possibili: perché un ospedale non può avere un giardino con degli ulivi? Perché un bambino non può essere accompagnato dai propri famigliari per tutto il tempo? Perché un bambino o un ragazzo non possono girare liberamente? Dalla nostra storia si potrebbero trovare alcune idee per migliorare il rapporto tra medico e paziente; si potrebbe diffondere l’idea che il malato entrando in ospedale non interrompa la propria vita e, soprattutto, non venga identificato con la sua malattia. Un ragazzo malato di tumore è prima di tutto un ragazzo; nella sua vita c’è la malattia, certamente, ma ci sono anche tante altre cose: l’amore, l’amicizia, i sogni.